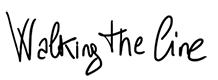L'armata delle ombre
Sono stanco, ma non posso fermarmi proprio ora. Questo vento di giugno, freddo, s’infrange sulla mia camicia sudata. Non c’è tempo per il dubbio, non c’è tempo per la paura. Li vedo. Si muovono tutto attorno, sulle cime delle colline, nei sentieri che scendono a valle, dall’altra parte della ferrovia. Guardano.
Le gambe sono pesanti. Mi sembra di avere due sassi legati alle caviglie. Non mi devo fermare, non posso farlo. Chi lo ha fatto ha perso la casa, la terra, il villaggio.
Tutti dicono che è solo per qualche tempo, che poi si tornerà a casa, che basta avere pazienza. “Meglio non discutere, sono armati fino ai denti”, dicono. E poi: “Noi siamo solo contadini senza difesa, cosa possiamo fare contro un esercito?”.
Ma non mi fido. Questa terra è come il mio sangue, non possiamo vivere divisi. Se cediamo ora, non potremo tornare indietro. Sono degli illusi. Come possono pensare che chi si presenta a casa tua con un fucile sia un interlocutore affidabile?
E allora non resta che correre, avanti e indietro, di casa in casa. Battir è seduta nella sua valle, ma non deve apparire smarrita. Il villaggio deve sembrare vivo, pieno, pronto a difendersi. Come fare? Correndo.
Di casa in casa, di cortile in cortile. A casa di Hassan ho acceso una candela, a casa di Abu Nidal una lanterna nel patio. E poi giù, a rotta di collo, verso la fattoria di Umm Kamel, per far uscire le pecore. E intanto grido, cambio voce, chiamo persone che sono andate via.
Domando e rispondo da solo. Ogni tanto, di passaggio, sbatto una porta qui, muovo un albero là. E poi entro correndo nel pollaio di Rafiq, per far starnazzare le galline. Passo da casa di Hasna e Salwa, la sorelle, che hanno lasciato il bucato nelle ceste per fuggire. Lo stendo ad asciugare. E accendo un fuoco, nel loro cortile, bruciando sterpaglie.
Devo rifiatare, almeno un momento. Non di più, ma solo un momento. Non mi ricordo più da quanto non dormo, di mangiare non se ne parla: correndo di casa in casa prendo quel che trovo, un tozzo di pane, un pezzi di formaggio, un frutto. Lo mangio al volo, mentre corro via, da una casa all’altra, correndo a volte, camminando altre. Per farmi vedere.
Perché anche io vedo loro. Con i loro fucili. Che guardano, scrutano. Qualche volto mi sembra di riconoscerlo. Ma non è possibile, con questo buio. E’ la mia mente, è la stanchezza, che giocano dei brutti scherzi. E’ la rabbia, forse. Perché mi pare di riconoscere tra loro qualcuno che è arrivato anni fa, accolto, come un fratello. E poi è finita così, a fucilate.
Mio nonno non si fidava. Diceva che la terra non si deve mai lasciare, che la terra è tua solo fino a quando puoi affondarci i piedi. Che le carte bollate sono dei potenti: possono riconoscerle come dire che non sono mai esistite.
Aveva ragione. Il diritto esiste solo per i ricchi. Per noi c’è solo la terra, da difendere fino alla morte.
Ecco che si muovono ancora, in fila. Avanzano e indietreggiano. Mi sembra che non sappiano cosa fare, che siano indecisi. E’ proprio quello che volevo. E’ questo che mi dà l’energia per non crollare sotto il peso della stanchezza.
Devono pensare che siamo tanti, che siamo pronti a tutto per non andare via. Devo strappare un accordo, per tenere le nostre terre, i campi, dove c’è il sangue e il sudore di generazioni intere di persone.
Non posso fermarmi, la stanchezza è un lusso che non posso permettermi.
C’è un bucato da stendere, una lampada da accendere, un camino da far fumare, dei maiali da far urlare. E qualche colpo da sparare con la vecchia carabina. Che se la vedi non farebbe paura a nessuno, ma loro – mentre guardano – devono pensare che siamo armati.
Anche la paura è un lusso che non posso permettermi. Se capiscono che il villaggio è vuoto lo occuperanno, come hanno fatto altrove, o lo bruceranno. Ho portato anche i miei concittadini a vedere, di nascosto, quel che capitava ai villaggi vicini.
Speravo di convincerli a restare, ho ottenuto l’effetto opposto, si sono terrorizzati e sono scappati. Li capisco. Case che bruciano, i cadaveri per terra, bestie e raccolti devastati. Ma mollare adesso, significa perdere tutto.
Nessuno verrà a salvarci, né i fratelli arabi, che hanno combattuto con noi, ma che sono stati abbandonati dai loro governi, né la comunità internazionale, che non muove un dito, pur assistendo a tutto questo.
Siamo noi, la nostra storia, la nostra terra. Dobbiamo restare, altrimenti faremo la fine degli altri. E perderemo tutto. Che non è tanto, magari, ma per noi è un mondo intero.
Mustafà Hassan, figlio di un influente leader della comunità di Battir, era stato tra i primi a capire che dopo la Seconda Guerra mondiale la situazione in Palestina evolveva verso la nascita di uno Stato israeliano, mentre non era certo che la comunità araba sarebbe stata difesa da nessuno.
La sua battaglia politica avvenne su radio e giornali, oltre che nel territorio di Battir, dove animò un circolo di intellettuali all’avanguardia che vedeva in un’agricoltura moderna e sostenibile il futuro del suo villaggio e della Palestina.
Nel 1948, quando il conflitto deflagrava, pur avendo buoni rapporti con la resistenza palestinese, la riteneva inadeguata. Aveva organizzato forme di vigilanza delle terre, che per lui erano il bene strategico del conflitto. Ma di fronte all’avanzata di militari e paramilitari israeliani in tanti fuggivano.
Lui, assieme a meno di dieci ragazzi del villaggio, restò. Per difendere Battir, strategicamente importante perché collocato lungo quello che sarebbe dovuto diventare il confine tra Israele e Palestina, con la sua ferrovia.
Lo difese, per giorni, fingendo che il villaggio fosse abitato. Facendo riparare nelle grotte delle montagne vicine gli abitanti, e restando a correre di casa in casa. Arrivando infine ad un accordo con i militari israeliani che resiste ancora oggi, che ha salvato il villaggio e il suo futuro.
Mustafà Hassan è morto negli anni Sessanta. Si racconta che di lui il generale israeliano Moshe Dayan abbia detto: “Con un altro come lui, avremmo perso la guerra”.