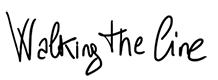Intervista con JAMIL HILAL
“Il significato del ’67, per me, come sociologo e come cittadino palestinese, ma anche e soprattutto come essere umano, è che l’intera Palestina è stata occupata. Nel suo insieme, non solo la zona del ’67 come era prima della guerra, l’intero paese”.
Jamil Hilal, mentre alle sue spalle scorre il frastuono del traffico di Ramallah, sorseggia il suo caffè, scrutandone il fondo, dietro le lenti spesse dei suoi occhiali. Le parole non le cerca; ci sono. Come se il “Caffè Roma” fosse solo una cornice, senza fisicità. Potrebbe essere ovunque, potrebbe essere il 1967.
Docente alla Birzeit University, Senior research fellow al Palestinian Institution for the Study of Democracy di Ramallah, membro dell’editorial board dell’Institute for Palestinian Studies, Jamil Hilal è tra le voci più autorevoli di una generazione di intellettuali che ha lottato a lungo per la liberazione, dentro le istituzioni ma soprattutto nelle strade. Le sue analisi e le inchieste realizzate in questi anni restano un lavoro fondamentale per chi tenta di capire questa terra stretta.
“Dopo la guerra, l’annessione di Gerusalemme Est e l’avvio della colonizzazione e costruzione degli insediamenti, è proseguito un processo che era stato avviato nel 1948. Si è semplicemente espanso, e ancora oggi continua a farlo, non si è arrestato. Il percorso degli Accordi di Oslo non è riuscito a fermarlo, ma solo a nasconderlo, oscurarlo. Per l’establishment israeliano ciò che è chiamata ‘Green Line’, la linea dell’armistizio, non esiste più. Perché gli insediamenti sono andati molto oltre, così come le infrastrutture dell’occupazione, cui si è aggiunta la divisione in aree A, B e C del territorio occupato. Nessun punto degli Accordi oggi viene rispettato. La nostra storia, quel che successe nel ‘67, fu in qualche modo la riunificazione con la forza delle due parti della Palestina storica: cessarono sia il controllo giordano sulla Cisgiordania, che quello egiziano sulla Striscia di Gaza, e i palestinesi che non erano rifugiati, che erano rimasti in Palestina, furono in qualche modo riuniti ma con un’identità ormai oscurata”.
L’occupazione come un destino, l’occupazione come smarrita, violenta forma di riunificazione, condizione condivisa e ineluttabile. Per quanto nel discorso pubblico, nazionale e internazionale, resti una sorta di punto di riferimento, di confine, di trattativa. E se invece fosse una prigione nella prigione?
“Oggi vediamo che la narrativa ufficiale, compresa quella internazionale, dei mass media, della stessa Autorità Palestinese, vuole la questione palestinese ridotta ad un mero tema di ‘occupazione’, quella che ha fatto seguito alla guerra del ‘67. Il resto è completamente scomparso. Dopo Oslo la richiesta non è più stata autodeterminazione per il popolo palestinese, ma libertà per porre fine all’occupazione”.
Un sottile, ma profondissimo stravolgimento di senso. Una situazione di aggressione e violazione del diritto internazionale che diventa, per paradosso, una forma di deresponsabilizzazione collettiva, un luogo dove la vittima può utilizzare gli stessi strumenti della sua oppressione per non rendere conto del suo operato. Hilal non ha dubbi, e neanche troppe speranze.
“Porre fine all’occupazione e costruire lo Stato di Palestina sul 22 per cento del territorio rimasto: è quello su cui l’Autorità Palestinese sta lavorando, il massimo dell’ambizione espressa nei negoziati che sono andati avanti in questi anni. Sono scomparsi i diritti dei palestinesi discriminati nel territorio israeliano, pari al 20 per cento della popolazione, così come quelli dei rifugiati in diaspora (Giordania, Libano, Siria). Il diritto al ritorno, che era parte della Risoluzione 194 delle Nazioni Unite, è stato dimenticato. Parte della conseguenza di questa nuova narrativa è stata che i palestinesi sono stati ridotti a coloro che vivono in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza”.
Il ’67 di Hilal è cupo, come un presagio, allo stesso tempo profezia avverata del ’48 e monito di un futuro smarrito. E la domanda da porsi, a suo avviso, è chi siano i palestinesi oggi.
“Perché il significato del ’67 è stato anche questo: il cambiamento profondo di narrativa sulla questione palestinese e sulla sua percezione. Che ha avuto un impatto politico fortissimo, anche alla luce dell’epica disfatta degli Stati arabi”, spiega.
Un mutamento di senso, di racconto, ma anche di relazione. Non solo tra l’occupante e l’occupato, ma anche tra gli occupati. Quanto il ‘67 ha nascosto le reali responsabilità della Autorità Palestinese? Quanto ha influenzato le relazioni tra il popolo e l’autorità, gli domandiamo.
“L’Autorità Palestinese (AP) non ha il supportodella popolazione, anche perché l’impianto di Oslo non è più operativo, non serve più. L’AP è ormai usata come provider di servizi per l’occupazione e soprattutto per garantire sicurezza agli israeliani: questa è la reale funzione del cosiddetto ‘coordinamento di sicurezza’ tra le forze di occupazione e l’AP, cui viene destinato la maggior parte del budget statale. Sia qui che a Gaza, l’unica differenza sta nel partito che controlla la polizia. Credo che scegliere di investire nel controllo delle opposizioni, e non nelle necessità della popolazione, sia stato uno dei più grandi fallimenti sul nostro fronte. Se a questo si aggiunge la profonda debolezza della nostra economia, si comprende bene il sentimento di alienazione del popolo verso l’autorità. Si tratta di élites politiche ed economiche distanti dalla popolazione, basta guardare al loro stile di vita per comprenderlo”.
Un lento declino, un distaccamento dalla propria lotta, e in fondo da se stessi e dalla propria identità. Che per Hilal ha una data precisa.
“Inizia con la fine di Arafat. Finché c’era lui l’establishment provava vergogna ad ostentare ricchezza. Ed ha visto l’apice dopo l’era di Salam Fayyad, che ha adottato misure economiche neoliberiste per incoraggiare i prestiti da parte delle banche perché i capitali fossero investiti all’interno del paese, dal momento che fuori era impossibile farlo. E’ diventato semplice per chiunque acquistare proprietà, case, automobili. Ma la mentalità si è guastata: è diventata completamente individualista. In fondo, se non si potevano trovare soluzioni collettive alla nostra questione, che almeno se ne trovassero a livello personale, questa era l’idea”.
Oggi, cinquanta anni dopo, la guerra del ’67 resta come una cicatrice che non si rimargina, non arriva mai ad essere passato doloroso, ma resta un presente di amarezza. Anche a livello culturale, con le sue conseguenze, che per Hilal sono profonde. E non riguardano solo la Palestina.
“Credo che l’islamizzazione e il fondamentalismo siano stati incoraggiati da due fattori almeno: primo, la sconfitta del ’67 per il mondo arabo, e delle forze più progressiste e socialiste. Parte del successo dell’Olp, la ragione per cui divenne tanto popolare, fu proprio perché forniva un’alternativa a quei regimi che avevano fallito. Restituendo potere al popolo. Il secondo, che nel ’79, mentre l’Egitto firmava il suo accordo di pace con Israele, ci fu la rivoluzione islamica in Iran, che diede forte impulso all’Islam radicale. Il terzo fattore, molto importante, è che nella guerra del ‘73 il prezzo del petrolio salì a dismisura, dando potere ai Paesi del Golfo come l’Arabia Saudita, patria del wahabismo. La gran parte dei soldi sono andati insomma a Paesi che si facevano portatori di ideologie radicali. Il centro del mondo arabo è cambiato, e soprattutto il cuore dei suoi capitali. Qui, in Palestina, abbiamo vissuto parallelamente la diaspora economica della classe colta, che a partire dagli anni ’60 ha iniziato ad emigrare nel Golfo in cerca di lavoro; e l’emergere di Hamas, nel pieno della Prima Intifada, considerata una valida alternativa alla resistenza laica dell’Olp”.
Poi, c’è il modo in cui la guerra cambia le carte anche all’interno di una popolazione che, nella lotta, si riscopre parte di un tutto. E anche in questo il ’67, per Hilal, fu punto di svolta unico, confine netto tracciato tra un prima di dispersione, e un dopo di rivolta.
“La principale, evidente conseguenza del 1967 fu la politicizzazione di massa della popolazione palestinese, e la sua organizzazione strutturata in ogni settore della vita pubblica. Cambiò profondamente il modo in cui le persone si percepivano e si relazionavano tra loro. Fu una partecipazione di massa, che morirà con Oslo e con lo smantellamento dell’Olp. Credo sia stato un elemento davvero centrale: con l’inizio dell’occupazione iniziò anche il nostro organizzarsi per combatterla: qualcosa che dalla Nakba non si era più visto, anche a causa della frammentazione della popolazione palestinese. Il ‘67 ci ha riunificato come popolo in lotta. Paradossalmente fu un’ondata di nuova speranza, perché ci fece sentire uniti come combattenti per la libertà. Compresi i rifugiati costretti oltre confine, che si sentirono parte di un movimento nazionale, di un popolo”.
Vivere fuori dai margini di uno stato che non c’è, ma proprio per questo riuscire a sentirsene parte, come se il confine fosse obiettivo e colpa, mezzo e fine. E il ’67 di quel confine è diventato un paradigma, secondo Hilal, nella coscienza collettiva palestinese.
“Per noi palestinesi ‘confine’ ha sempre significato ‘barriera’. E’ dove veniamo fermati e interrogati. E’ dove i nostri diritti vengono violati, dove ci accorgiamo di non avere documenti uguali a quelli del resto del mondo. Dove la nostra libertà di movimento è negata e dove non veniamo trattati come esseri umani. Ha un significato politico, ‘confine’. E’ dove veniamo umiliati. E’ dove, anche se lo abbiamo dimenticato, dobbiamo necessariamente ricordare di essere palestinesi”.
Un anniversario, per sua natura, guarda indietro, non avanti. Me è lo sguardo sulla sua profondità, la sua essenza, che restituisce un’idea di futuro. O no?
“Nel ‘67 successe che i palestinesi, che non avevano confini, improvvisamente scoprirono di averne. E oggi li hanno ancora, solo che il confine è diventato una cortina di ferro. Io non credo che ci sia una soluzione in grado di soddisfare davvero il desiderio di autodeterminazione che abbiamo, basato su un concetto di giustizia ormai dimenticato. Formalmente, continueremo a ribadire di volere uno stato, così come abbiamo sempre fatto da Oslo in avanti. E che lo vogliamo sui confini del ’67. Anche se è un’illusione. E, in fondo, credo lo sia sempre stata”.